La strana normalità di bilancio di un paese indisciplinato.
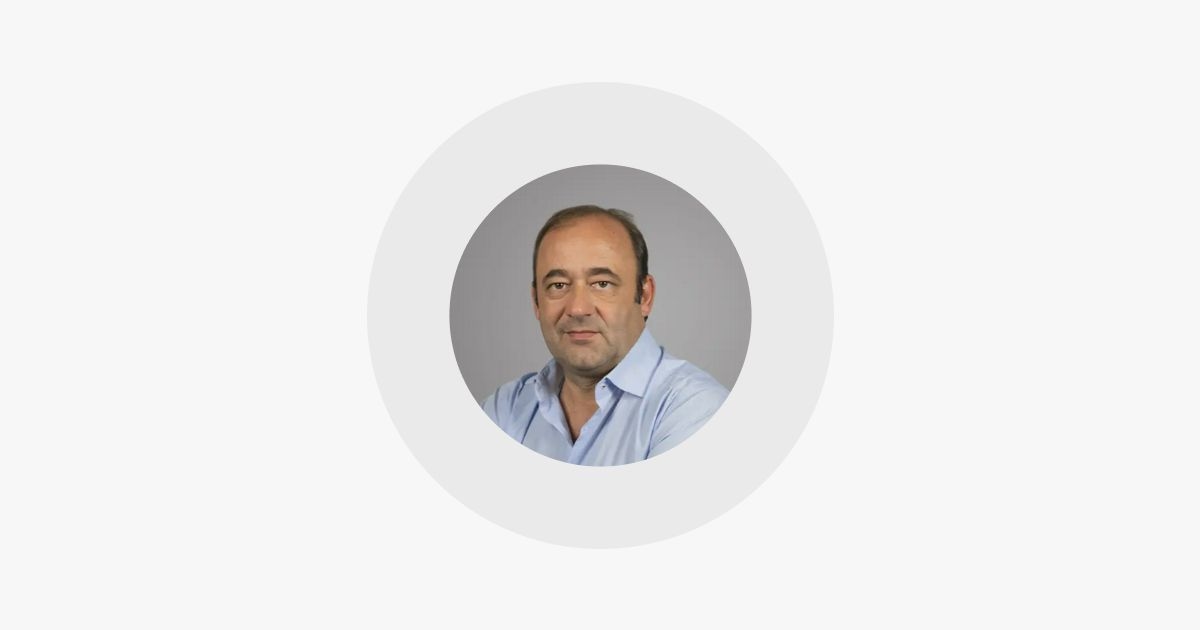
È ingiusto affermare che il Paese non attua riforme strutturali. Non tutte quelle che dovrebbe, è vero, ma ce n'è una che è stata fatta negli ultimi 15 anni: l'ampio consenso instaurato sulla necessità di prevedere e raggiungere il pareggio dei conti pubblici o lievi avanzi di bilancio.
Questo punto di partenza è diventato la norma nelle discussioni di bilancio. Possiamo e dobbiamo discutere su dove indirizzare la spesa e quali imposte imporre, ma senza alterare il saldo finale, che dovrebbe essere positivo.
Un percorso iniziato nel 2011, con la dura attuazione delle condizioni imposte dal salvataggio finanziario, e che ha già attraversato diversi governi e situazioni politiche.
Ammetto che il modo in cui siamo arrivati all'equilibrio rappresenta, in definitiva, solo metà di una riforma strutturale. Perché? Perché l'aggiustamento non ha toccato la spesa pubblica corrente, che è aumentata strutturalmente anno dopo anno, ed è stato realizzato esclusivamente con le variabili più semplici: più tasse e tagli indiscriminati agli investimenti.
Tuttavia, stabilire l'obiettivo del "deficit zero" rappresenta un cambiamento culturale molto significativo. È un principio perché, come sappiamo, il nostro precedente stile di vita prevedeva l'aumento della spesa pubblica, l'aumento delle tasse e la creazione di ingenti deficit che si accumulavano in debito. Finché questo non è diventato insostenibile, e il resto è storia.
La differenza tra prima e dopo il consenso sul pareggio di bilancio – che, ironicamente, è stato raggiunto durante un governo sostenuto dall'estrema sinistra – è impressionante. Prima, il dibattito verteva su quali tasse aumentare; ora il dibattito verte su quali tasse tagliare. Prima, si cercava di mascherare il deficit per sfuggire alle sanzioni di Bruxelles; ora siamo tra i Paesi dell'eurozona con i conti più in pareggio. Prima, i limiti massimi del debito venivano testati con la vecchia idea che "il debito si gestisce, non si paga"; oggi sappiamo che non è così che funzionano le cose, e i ministri delle finanze amano ostentare rapporti debito/PIL sempre più bassi.
Siamo arrivati al punto in cui un governo può essere penalizzato nella sua popolarità e nei risultati elettorali se inizia ad accumulare deficit senza una buona ragione: una pandemia, per esempio? Non lo sappiamo, ma è una speranza che dovremmo coltivare.
E dobbiamo coltivare questo aspetto perché il passo successivo comporterà inevitabilmente la riforma della spesa pubblica. Senza il deficit come variabile di aggiustamento, e con il pesante carico fiscale che già abbiamo, i futuri aggiustamenti dovranno comportare la razionalizzazione della spesa pubblica. Ciò non richiede tagli nominali ai livelli di spesa. È sufficiente che, anno dopo anno, la spesa pubblica aumenti a un tasso inferiore alla crescita nominale del PIL.
È quello che è successo con il debito. L'importo aumenta di anno in anno, ma il suo peso in un'economia in crescita si riduce sempre di più.
A questa normalità del saldo di bilancio si aggiunge ora la normalità del processo di bilancio. Il Bilancio dello Stato non è, e non può essere, un voto di fiducia annuale a cui si sottopongono i governi di minoranza. Il Bilancio deve essere, innanzitutto, un riflesso finanziario degli impegni dello Stato e delle leggi vigenti. Il margine rimanente, relativamente esiguo, deve poi riflettere le scelte politiche che ciascun governo compie caso per caso.
Negli ultimi anni ci siamo abituati a considerare il Bilancio come l'unico evento legislativo dell'anno, in cui si accumulavano tutte le politiche settoriali e centinaia di misure isolate, che avevano poco o nulla a che fare con il bilancio.
Un anno fa, i partiti politici hanno presentato circa 2.000 proposte di emendamento durante il dibattito specialistico sul bilancio. Tra gli esempi figurano: la valutazione annuale dello stato di salute del personale delle forze di sicurezza, l'interruzione della privatizzazione della TAP (la compagnia aerea portoghese), la promozione del lavoro dei tessitori di tappeti di Arraiolos e degli artigiani di statuette di Estremoz, la modernizzazione dei metodi di pagamento per le richieste di verifica dei permessi per malattia, la revisione del percorso di carriera degli ispettori fiscali e così via.
Il risultato di questa pratica è una qualità legislativa estremamente scadente: i membri del parlamento, nelle loro lunghe sessioni-maratona, hanno prestato poca attenzione a ciò su cui stavano votando e una mancanza di discussione indipendente su ciascuna di queste proposte.
José Luís Carneiro ha fatto bene a porre come condizione per la decisione del governo l'esclusione dal bilancio di questioni rilevanti come la revisione delle leggi sul lavoro, le modifiche alla previdenza sociale o le modifiche alla struttura del Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di questioni di grande importanza, che traggono beneficio solo se discusse e decise separatamente dal bilancio.
E Joaquim Miranda Sarmento ha fatto bene a preparare e presentare un bilancio che, dopotutto, è proprio questo: un bilancio. Eravamo così dipendenti dalle cattive pratiche precedenti che ora ci sorprendiamo persino di vedere ogni cosa al suo posto.
observador





