Perché parliamo da soli?

Chiunque abbia mai osservato un bambino giocare avrà notato che borbotta frasi su ciò che sta facendo o pensando: "Ora costruirò questa casa", "Il bambino dormirà perché ha sonno", "Attenzione, sta arrivando il drago". Il bambino non sta parlando con nessuno, o meglio, sta parlando con se stesso.
Questo comportamento fu osservato per la prima volta da Lev Vygotsky, uno psicologo russo che studiò i bambini negli anni '20, il quale concluse che questo tipo di linguaggio è una parte essenziale del processo di sviluppo, consentendo al bambino di organizzare i pensieri, regolare il comportamento e, probabilmente, interiorizzare il linguaggio, che sta ancora imparando, come strumento di pianificazione e risoluzione dei problemi.
E anche se da adulti potremmo sentirci in imbarazzo ad ammetterlo, o vergognarci quando veniamo scoperti, la maggior parte di noi continua ad avere conversazioni con se stessa, a volte ad alta voce, a volte solo nella nostra testa. Si tratta di un comportamento molto comune che gli psicologi e i ricercatori in questo ambito chiamano dialogo interiore , che può essere suddiviso in discorso privato (quando parliamo a noi stessi ad alta voce) e discorso interiore (quando parliamo a noi stessi solo attraverso i nostri pensieri).
"Le persone parlano da sole per una varietà di motivi. Ad esempio, per aiutarsi a gestire un problema, per motivarsi, per generare nuove idee o per migliorare le interazioni sociali", spiega Charles Fernyhough, direttore del Centre for Research into Inner Experience presso l'Università di Durham nel Regno Unito e autore del libro "The Voices Within" . Secondo il ricercatore, gli studi dimostrano che questo tipo di discorso è benefico durante l'infanzia, aiutando i bambini a risolvere i problemi e a mantenere l'attenzione e, sebbene ci siano meno ricerche su questo argomento negli adulti, vi è motivo di credere che abbia alcuni degli stessi effetti positivi.
Sebbene sia difficile quantificare questo fenomeno, alcuni studi indicano che il 96% degli adulti ha questi dialoghi interiori, mentre il 25% afferma di parlare da solo ad alta voce . “È noto che i bambini tendono a parlare ad alta voce tra sé e sé, mentre gli adulti tendono a farlo in silenzio, ma che in situazioni difficili possono anche ricorrere al dialogo privato [ad alta voce].”
È quanto può dirvi Thomas Brinthaupt , professore emerito alla Middle Tennessee State University , negli Stati Uniti, dove svolge ricerche nei campi della psicologia della personalità, della psicologia sociale e della psicologia dell'identità. Ricorda di essersi accorto per la prima volta di parlare da solo ad alta voce quando, più di 30 anni fa, è diventato padre e ha iniziato ad affrontare il problema della privazione del sonno. Questo è ciò che lo ha portato a questo ambito di ricerca, per cercare di rispondere alla domanda: “Dopotutto, qual è la funzione del parlare a noi stessi?”
Dopo tre decenni e decine di studi sull'argomento, riesce a riassumere la risposta a questa domanda in una frase sorprendentemente semplice: " Probabilmente ci sono tante ragioni per parlare con se stessi quante ce ne sono per parlare con gli altri ", inizia rispondendo. Nonostante questo, afferma che la ricerca ha dimostrato che “ una delle funzioni più comuni è l’autoregolazione , cioè il tentativo di controllare o modificare i nostri pensieri e comportamenti”.
La Self-Talk Scale (STS) , una scala da lui sviluppata per misurare e identificare i vari tipi di dialogo interiore, identifica anche altre funzioni, "come l'autocritica (ad esempio, quando siamo arrabbiati con noi stessi), l'auto-rafforzamento (cioè, quando siamo soddisfatti di noi stessi), l'autogestione (vale a dire cercare di capire cosa dobbiamo fare) e la valutazione sociale (come anticipare o ripetere le interazioni sociali)." Esistono anche altre scale e studi sviluppati da altri autori che fanno riferimento alle funzioni del dialogo interiore come il tentativo di memorizzare o richiamare informazioni, cambiare prospettiva su una situazione o un problema e rivivere conversazioni già avute con altre persone .
Quanto al fatto che solitamente è più comune per noi avere queste conversazioni solo dentro di noi, senza parlare ad alta voce, Thomas Brinthaupt sottolinea che, nonostante ci siano poche ricerche sull'argomento, una delle ragioni è l'inibizione sociale, cioè le persone si imbarazzano a essere sorprese a parlare da sole perché ciò viene associato a idee come quella di essere pazze o di avere un problema di salute mentale. Per questo motivo, tendiamo generalmente a limitare il dialogo interiore ad alta voce alle situazioni in cui è socialmente accettabile. "Come quando un oratore dice: 'OK, dove ero rimasto?'; quando una persona cerca di capire cosa c'è che non va nel suo computer e dice: 'Perché non funziona?' o quando gli atleti cercano di motivarsi o concentrarsi durante una competizione, dicendo, ad esempio, "Puoi farcela!"
E sebbene sia vero che a volte il dialogo interiore, soprattutto quando si tratta di un discorso disordinato o incoerente, può essere sintomo di un disturbo mentale, il più delle volte è solo un modo normale, molto comune e sano di cercare di elaborare e organizzare i nostri pensieri, le nostre emozioni e i nostri comportamenti.
Mental è una sezione di Observador dedicata esclusivamente ad argomenti legati alla salute mentale. È il risultato di una partnership con l'Hospital da Luz e Johnson & Johnson Innovative Medicine e si avvale della collaborazione del Collegio di Psichiatria dell'Associazione Medica Portoghese e dell'Associazione degli Psicologi Portoghesi. Si tratta di contenuti editoriali completamente indipendenti.
Una partnership con:


Con la collaborazione di:
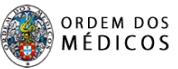

observador





